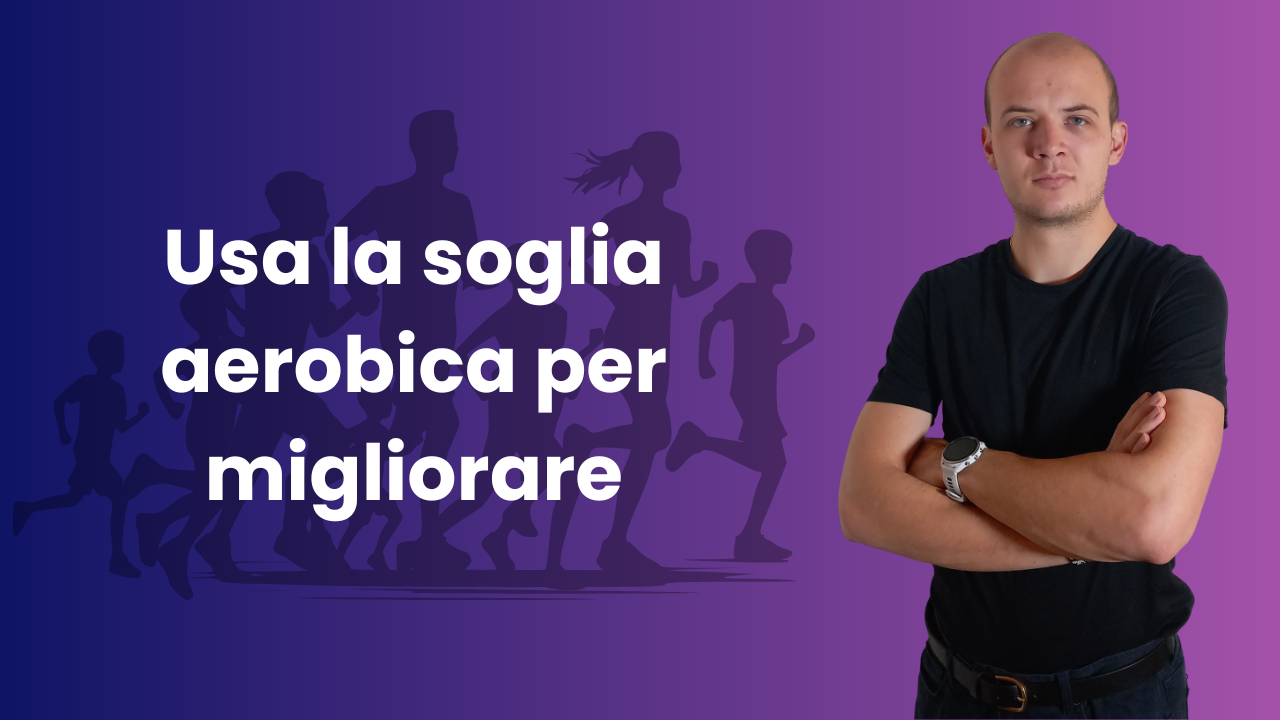Soglia aerobica: tutto ciò che devi sapere per migliorare
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI YOUTUBE
Di sicuro hai sentito parlare di soglia aerobica. È uno dei valori più importanti per quanto riguarda l'allenamento degli sport di resistenza. Ma cos'è effettivamente questa soglia? A cosa serve? Non ti preoccupare perché in questo articolo ti spiego tutto quello che c'è da sapere sulla soglia aerobica e come la puoi utilizzare nei tuoi allenamenti.
Eccoci qua! Io sono Alberto, allenatore di corsa certificato UESCA e appassionato di sport. Di cosa mi occupo? Realizzo programmi di allenamento personalizzati per atleti di ogni livello e li aiuto a raggiungere i propri obiettivi sportivi. Se ti piacciono i video sulla corsa e sull'allenamento, visita il mio canale YouTube. Se vuoi farti allenare da me, oppure vuoi saperne di più su come posso aiutarti, visita il mio sito.
Oggi parliamo di un tema molto caldo per quanto riguarda l'allenamento della corsa, e in generale degli sport di resistenza, ovvero la soglia aerobica. Quindi cos'è questa soglia aerobica? A cosa serve? È effettivamente utile? E come possiamo utilizzarla all'interno dei nostri allenamenti? Inizio col dire che, se prendiamo in considerazione tutte le intensità che possiamo tenere all'interno di un nostro allenamento, quindi da una corsa molto leggera, fino ad uno scatto alla massima velocità, esistono solo tre pattern di risposte fisiologiche che il corpo ci dà, in base allo sforzo che stiamo esercitando. La soglia aerobica è una delle due soglie che definiscono le reazioni fisiologiche del corpo a diverse velocità. La seconda soglia è la soglia anaerobica. In questo articolo mi concentro solo sulla prima perché altrimenti diventerebbe troppo lungo. Per spiegarlo in un modo molto semplice, la soglia aerobica fa da confine tra i ritmi lenti, quindi a bassa intensità ed i ritmi ad intensità più moderata.
Da un punto di vista fisiologico, la soglia aerobica indica quel punto in cui il sistema aerobico incontra le sue prime difficoltà. Ciò non significa che i ritmi superiori alla soglia aerobica siano anaerobici, anzi, l'attività del sistema aerobico cresce in proporzione allo sforzo sostenuto.
Quando corriamo al di sotto della soglia aerobica, quindi a bassa intensità, il principale cambiamento fisiologico che avviene è l'aumento del consumo di ossigeno: il consumo di ossigeno aumenta per i primi 2-3 minuti di attività per poi stabilizzarsi. I valori di lattato, ad intensità bassa, sono quasi indistinguibili dai valori basali. Per quanto riguarda diverse velocità al di sotto della soglia aerobica, il consumo di ossigeno cresce in modo lineare all'aumentare della velocità, per poi stabilizzarsi nel lungo periodo. La produzione di anidride carbonica e la ventilazione aumentano in modo proporzionale al consumo di ossigeno. Quindi se ci avviciniamo alla soglia aerobica, il consumo di ossigeno sarà più alto e di conseguenza la produzione di anidride carbonica e la ventilazione, che sarebbe la quantità totale di aria che viene inspirata, aumentano in modo proporzionale.
Tra i valori che non rimangono costanti sul lungo periodo, al di sotto della soglia aerobica, il più rilevante è la frequenza cardiaca. Questo perché, a velocità costante, la frequenza cardiaca sul lungo periodo tende ad aumentare (questo è il concetto di deriva cardiaca). L'altro valore è l'ossidazione dei grassi: a bassa intensità il corpo utilizza principalmente grassi per la produzione di energia; quindi, a bassa intensità ci sarà una bassa richiesta di energia e di conseguenza un basso consumo di grassi. Mano a mano che l'intensità aumenta, quindi ci si avvicina alla soglia aerobica, questo consumo aumenta, fino ad arrivare al suo picco, conosciuto anche come Fatmax.
Le cause della fatica che si percepisce al di sotto della soglia aerobica sono principalmente due: il danneggiamento delle fibre muscolari e la cosiddetta fatica centralizzata, ovvero, per spiegarla in un modo molto semplice, quella fatica che ci fa percepire il cervello e il sistema nervoso.
Quando, aumentando la velocità, superiamo la soglia aerobica, ci troviamo a correre ad intensità moderate. Il consumo di ossigeno aumenterà per ulteriori 5-10 minuti prima di stabilizzarsi, mentre la produzione di anidride carbonica e la ventilazione aumenteranno in modo più che proporzionale al consumo di ossigeno. I valori di lattato, ad intensità moderata saranno notevolmente superiori ai valori basali (di solito almeno +0,5 mmoL/L).
Aumentando la velocità, l'ossidazione dei grassi diminuisce perché entra in gioco la sintesi di carboidrati. Superata la soglia aerobica e il Fatmax, il corpo inizierà ad utilizzare carboidrati per la produzione di energia e di conseguenza l'ossidazione dei grassi diminuirà.
A questa intensità, oltre al danneggiamento muscolare e alla fatica centralizzata, si aggiunge un terzo fattore che è la fatica periferica. Anche questa spiegata in modo semplice, è la fatica muscolare che si percepisce a causa del deperimento delle scorte di glicogeno, quindi di carboidrati, nel muscolo.
Ora voglio fare un po' di chiarezza per quanto riguarda la terminologia della soglia aerobica. Se cercate online, troverete molte terminologie diverse per quanto riguarda la soglia aerobica e molti acronimi diversi. L'acronimo più popolare è probabilmente AeT, a volte scritto anche AT. Sta per, in inglese, Aerobic Threshold, quindi soglia aerobica. Ripeto, ciò non significa che i ritmi superiori alla soglia aerobica siano anaerobici, ma l'attività del sistema aerobico aumenta in proporzione allo sforzo esercitato.
Un altro acronimo che potete trovare è GET: Gas Exchange Threshold. In questo caso si misura il rapporto tra consumo di ossigeno e produzione di anidride carbonica. Ad aumentare del consumo di ossigeno, aumenta la produzione di anidride carbonica. Ad un certo punto la produzione di anidride carbonica aumenta notevolmente rispetto alle intensità precedenti. Ciò corrisponde alla soglia aerobica. Purtroppo, nella maggior parte dei test di laboratorio, non si nota un cambiamento così repentino, ma il risultato è più simile ad una curva graduale, quindi identificare la soglia aerobica, usando questa metodologia, non è sempre semplice.
Altro acronimo VT1 o semplicemente VT: Ventilatory Threshold, quindi soglia ventilatoria. Stesso discorso che ho appena fatto, però invece che misurare la produzione di anidride carbonica, si misura la ventilazione, quindi la quantità totale di aria che viene inspirata.
Altro acronimo, il secondo più comune, ma forse quello più preciso, LT1 oppure LT, Lactate Thresold, quindi misurazione del latto. Generalmente la soglia aerobica viene associata col valore di 2 mmoL/L di sangue. Non è un valore che va bene per tutti gli atleti perché è troppo generico. Può essere più utile aggiungere 0,5 mmoL ai valori basali: se, per esempio, un atleta ha valori basali di 1 mmoL/L di sangue, la sua soglia aerobica sarà intorno agli 1,5 mmoL/L. Anche qui da prendere con le pinze.
È possibile determinare la soglia aerobica sulla base della frequenza cardiaca? Purtroppo, non c'è una percentuale di frequenza cardiaca che rappresenta in modo preciso la soglia aerobica. Nella maggior parte dei casi, 9 atleti su 10, se mantengono una frequenza cardiaca inferiore al 69% della frequenza cardiaca massima, oppure al 65% della riserva di frequenza cardiaca, “hanno la certezza di correre al di sotto della soglia aerobica”.
Per i fanatici del VO2Max, vi spiego la relazione che c'è tra soglia aerobica e VO2Max per persone con diversi livelli di preparazione: persone sedentarie, che non svolgono attività fisica, avranno una soglia aerobica molto vicina al loro VO2Max; questo perché hanno poco margine (il loro VO2Max è molto basso). Atleti più attivi avranno la soglia aerobica più lontana rispetto al loro VO2Max, perché hanno alzato il soffitto del VO2Max. Gli atleti più evoluti, quelli più allenati, che si sono allenati per rialzare la soglia aerobica, l’avranno nuovamente vicina al 100% della VO2Max. Per rendere il discorso un po' più chiaro, lo spiego in valori assoluti: una persona sedentaria avrà un basso VO2Max e la soglia aerobica, rappresentata dal volume di ossigeno consumato, sarà molto bassa. All'aumentare della preparazione dell'atleta la sua soglia aerobica, sempre rappresentata dal volume di ossigeno consumato, sarà più alta.
Se non riuscite a fare dei test di laboratorio, o ad effettuare delle misurazioni di lattato in modo autonomo, potete utilizzare il vostro ritmo maratona come ritmo di soglia aerobica. Non è estremamente preciso, però se non avete altro su cui affidarvi, può andare bene. Se non correte maratone, esistono dei calcolatori online che vi aiutano a calcolare il vostro ritmo maratona: vi chiedono di inserire un vostro record personale su una certa distanza e loro calcolano il vostro ritmo maratona.
Come utilizzare la soglia aerobica all'interno dei nostri allenamenti? Per quanto riguarda gli allenamenti a bassa intensità, quindi lenti e lenti di recupero, si corre al di sotto della soglia aerobica. Invece, se dobbiamo allenare degli stimoli più specifici per le gare che stiamo preparando, lavoriamo al di sopra della soglia aerobica. Quando si tratta di resistenza, quindi allenamenti di medio o progressivo, si corre ad intensità moderata. Se vogliamo lavorare sulla capacità aerobica delle fibre veloci, che sono le fibre che vengono reclutate superata l'intensità della soglia aerobica, dobbiamo lavorare ad intensità moderata. Stessa cosa se vogliamo lavorare sulla resilienza fisiologica e sulla nostra capacità di mantenere un'intensità elevata e una velocità elevata, con scarse riserve di glicogeno.